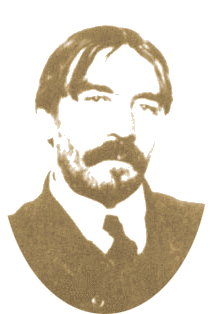Democrazia nell'impresa e nella società. La proposta di Bruno Jossa
 La cooperativa Mondragon, situata nei Paesi Baschi, rappresenta un caso da manuale di impresa gestita dai lavoratori.
La cooperativa Mondragon, situata nei Paesi Baschi, rappresenta un caso da manuale di impresa gestita dai lavoratori.JOSSA B.: Esiste un’alternativa al capitalismo? L’impresa democratica e l’attualità del marxismo, Manifestolibri, Roma, 2010, pp. 446, ISBN: 978-88-7285-644-4, € 36,00.
Il libro di Bruno Jossa costituisce uno dei rari tentativi volti a proporre una forma di organizzazione economica alternativa al capitalismo e si muove nel solco tracciato da autori come Meade (1989), Roemer (1994), Schweickart (2002), che hanno presentato in un recente passato proposte di matrice socialista.
L’autore delinea un sistema produttivo composto in prevalenza da imprese gestite dai lavoratori, definite equivalentemente imprese democratiche o cooperative di produzione, in cui la sovranità appartiene ai lavoratori. Questi ultimi eleggono periodicamente gli amministratori che di fatto gestiscono correntemente l’impresa, mentre l’assemblea dei soci viene investita dei fatti più rilevanti quali l’approvazione del bilancio, la nomina o revoca degli amministratori, i piani strategici e quelli di natura straordinaria. Secondo Jossa il finanziamento delle cooperative dovrebbe essere esclusivamente esterno. Non vi è apporto di capitale di rischio da parte dei soci, anche se essi, al pari dei finanziatori terzi, possono prestare capitali all’impresa restando, quindi, titolari di un credito. Il salario viene abolito e la retribuzione dei soci è costituita dal surplus, dato dalla differenza tra i ricavi e i costi di gestione. In questi ultimi sono inclusi, naturalmente, gli interessi pagati ai creditori sul capitale preso in prestito. Il residuo per i soci è così costituito, di fatto, dai redditi da lavoro e dal profitto.
L’eliminazione dell’autofinanziamento è necessaria per tenere distinto in modo costante il patrimonio dell’impresa da quello dei soci e per tenere separati i redditi di capitale da quelli da lavoro ed, eventualmente, da profitto. Al momento dell’uscita dall’impresa i soci conservano il diritto al rimborso dei loro eventuali crediti non ancora rimborsati, ma non possono vantare alcuna pretesa su eventuali residue plusvalenze dell’impresa. Con la forma di impresa proposta si ha il ribaltamento dello schema che è tipico del capitalismo. In essa, infatti, è il lavoro ad assumere il capitale, remunerandolo anticipatamente rispetto alla realizzazione e alla suddivisione del sovrappiù tra i lavoratori. La proprietà dell’impresa democratica spetta al collettivo dei soci e quindi, a rigore, non è una proprietà pubblica. Il singolo socio non può vantare diritti diversi da quelli di voto, nelle sedi stabilite, e di ripartizione del residuo.
Secondo l’autore un’economia di questo tipo non può definirsi capitalistica, perché inverte i rapporti di forza tra capitale e lavoro, ponendo quest’ultimo in una situazione di preminenza. Si tratta quindi di una forma di socialismo, perché viene abolito il lavoro salariato, ritenuto la caratteristica fondamentale del capitalismo. Poiché le imprese sono del tutto autonome e operano secondo le regole del mercato, istituto che mantiene tutte le sue funzioni, si tratterebbe di una forma di socialismo di mercato (cfr. anche Jossa, 2010). Un tale sistema sarebbe coerente col pensiero di Marx, perché supererebbe una delle contraddizioni fondamentali del capitalismo, la soggezione del lavoro al capitale e, inoltre, costituirebbe a pieno titolo una possibile fase di transizione verso il comunismo, prevista dai teorici del marxismo e tuttavia mai efficacemente descritta.
Quali sono i vantaggi di un sistema economico di questo tipo? Jossa ne descrive alcuni di estrema importanza: in primo luogo la democrazia economica rafforza e rende effettiva la democrazia politica; risulta ridotta l’alienazione del lavoro; vengono meno i presupposti dello sfruttamento. Inoltre è prevedibile un aumento della produttività del lavoro, perché il reddito dei soci è direttamente e interamente commisurato ai risultati. Un ulteriore aumento dell’efficienza del lavoro deriverebbe dal miglioramento del capitale umano, cioè dalla crescita delle conoscenze e abilità professionali dei lavoratori, perché i soci avrebbero un interesse diretto a investire nella loro formazione, essendo ora il lavoro, e non il capitale, il fattore specifico all’impresa. Si avrebbe, infine, una riduzione della disoccupazione, perché verrebbero meno due delle principali cause di essa: l’inesistenza del salario eliminerebbe la disoccupazione “neoclassica” da alto costo del lavoro, mentre la sovranità dei lavoratori, rendendo possibile l’adeguamento dell’orario di lavoro all’intensità della domanda di prodotti di ogni impresa, eliminerebbe la disoccupazione “keynesiana”, spalmando gli effetti delle crisi di domanda su tutti i lavoratori.
Nella terza parte del volume, dedicata alla teoria della transizione al socialismo, vengono abbozzati i meccanismi che dovrebbero condurre al nuovo modo di produzione fondato sull’impresa democratica. L’autore indica tre “vie”, la prima delle quali è costituita da agevolazioni di natura fiscale e creditizia che lo Stato dovrebbe concedere alle cooperative per facilitare la trasformazione verso tale forma delle imprese capitalistiche. La giustificazione deriverebbe dal carattere “meritorio” dell’impresa democratica che, rispetto a quella tradizionale, presenta i vantaggi che sono stati in precedenza elencati, i quali dovrebbero semplicemente essere riconosciuti dallo Stato. Il secondo meccanismo è di natura completamente diversa e consiste nella trasformazione in cooperative delle imprese tradizionali in gravi difficoltà e, di fatto, abbandonate dai proprietari. La terza via rappresenta invece un approccio radicale alla questione e consiste in una legge “del parlamento che trasformi le azioni delle imprese esistenti in obbligazioni di pari valore e proibisca nel contempo, nei limiti in cui ciò sia ritenuto opportuno, l’assunzione di lavoro salariato” (p. 271).
Si diceva all’inizio della peculiarità dell’opera di Jossa, che affronta un campo poco esplorato e che per questo motivo, soprattutto nelle indicazioni di policy, deve essere vista come un primo coraggioso tentativo di avvicinamento alle questioni proposte e uno stimolo ad una vasta discussione da parte degli intellettuali, a cui l’autore, sulle orme del pensiero di Hayek, affida il ruolo decisivo di selezione e diffusione delle idee che troveranno poi effettiva applicazione. Di seguito vengono indicati i punti che a mio parere dovrebbero essere oggetto di un più ampio dibattito. Lo stesso autore avverte che il sistema economico proposto rappresenta un passo avanti rispetto al capitalismo, ma è lontano dall’avere le caratteristiche di un mondo perfetto. Come è stato mostrato da Vanek (1970) e Meade (1974), le cooperative possono dare luogo a monopoli o ad altre forme di potere di mercato, al pari delle imprese tradizionali. Si potrebbero quindi avere casi di cooperative ricche e potenti, in grado di assicurare ai soci redditi molto alti, contrapposti a situazioni con redditi ai limiti della sussistenza. Verrebbero di conseguenza a replicarsi condizioni non dissimili da quelle che si riscontrano nelle economie capitalistiche e andrebbe quindi mantenuto e forse rafforzato il ruolo redistributivo dello Stato.
Punti di particolare delicatezza riguardano la fase di transizione verso un sistema economico costituito solo o in modo prevalente da cooperative. L’autore avverte di essere a favore di un passaggio graduale, e due delle tre “vie” indicate (ragionevoli agevolazioni dello Stato a favore delle cooperative e trasformazione in cooperative delle imprese capitalistiche in crisi) sono perfettamente coerenti con la progressività della transizione. Ma come interpretare la terza “via” che pure egli prospetta, quella di una decisione parlamentare che trasformi le azioni in obbligazioni e abolisca il lavoro salariato? In realtà essa può ancora essere in linea con la gradualità della trasformazione, se rappresenta la ratifica finale di un processo evolutivo che abbia raccolto un vastissimo consenso e sia suffragata da una situazione di fatto in cui le indicazioni del mercato siano univoche. Ciò può avvenire a seguito di una fase che porti ad una notevole riduzione delle disuguaglianze dei redditi e della ricchezza, dovuta non solo a politiche ad hoc da parte dello Stato, ma anche ad una crescita dell’importanza relativa del lavoro. Quest’ultimo fenomeno richiede che si verifichino cambiamenti strutturali dell’economia tali da provocare una crescita del contenuto di conoscenza del lavoro che non sia incorporabile nel capitale (o lo sia solo in misura limitata). Sarebbe quindi il riequilibrio dei rapporti di potere tra lavoro e capitale a rendere possibile la significativa espansione delle imprese gestite dai lavoratori auspicata da Jossa.
BIBLIOGRAFIA
JOSSA B. (2010), “Sulla transizione dal capitalismo all’autogestione”, Moneta e Credito, vol. 63 n. 250, pp. 119-155.
MEADE J.E. (1974), “Labor-managed firms in conditions of imperfect competition”, The Economic Journal, vol. 84 n. 336, pp. 817-824.
—— —— (1989), Agathotopia. The economics of partnership, Aberdeen University Press, Aberdeen; trad. it.: Agathotopia. L’economia della partnership, Feltrinelli, Milano, 1989.
ROEMER. J.E. (1994), A future for socialism, Harvard University Press, Cambridge (MA).
SCHWEICKART D. (2002), After capitalism, Rowmarr & Littlefield, Lanham (MD).
VANEK J. (1970), The general theory of labour-managed market economies, Cornell University Press, Ithaca (NY).
Autore: Gaetano Cuomo (Università di Napoli “Federico II”) e-mail: gaetano.cuomo@unina.it
Fonte: Moneta e Credito, vol. 64 n. 254 (2011), 177-180 http://scistat.cilea.it/index.php/MonetaeCredito/article/view/344/185
© Associazione Paolo Sylos Labini





 Quest'anno cadono gli anniversari di due grandi pensatori, Veblen (150° della nascita) e Gramsci (70° della morte). Gramsci cita l'economista americano nei suoi Quaderni del carcere,
Quest'anno cadono gli anniversari di due grandi pensatori, Veblen (150° della nascita) e Gramsci (70° della morte). Gramsci cita l'economista americano nei suoi Quaderni del carcere,